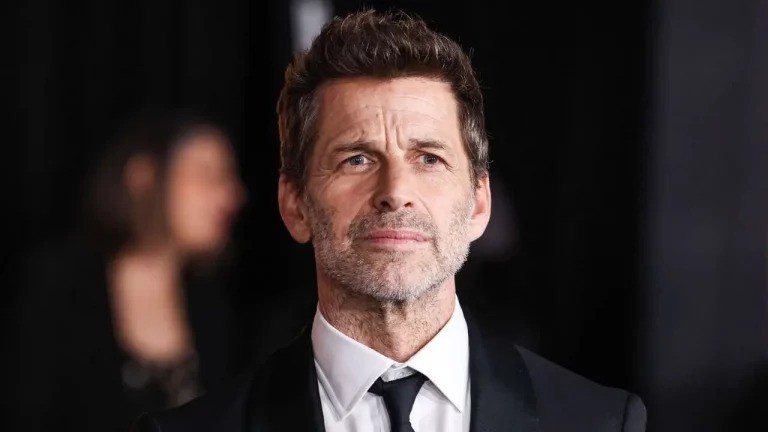Emily Cooper arriva a Parigi con una valigia troppo piccola per i suoi vestiti e troppo grande per le sue certezze. Sorride sempre, sbaglia poco, non impara mai davvero. Eppure Emily in Paris continua a essere una delle serie più viste, commentate e odiate degli ultimi anni. Il paradosso è tutto lì: mentre la Francia la respinge, il mondo la divora. E Netflix ringrazia. Perché il vero scoop non è che Emily in Paris sia superficiale. È che la sua superficialità è un progetto perfettamente riuscito.
Una fantasia globale
Quando la serie debutta, i francesi reagiscono con un misto di fastidio e imbarazzo: stereotipi, cliché, dialoghi che nessuno direbbe davvero e una Parigi da cartolina più che da città. Ma quella Parigi non è pensata per i parigini. È una fantasia globale, un filtro Instagram permanente. Darren Star, lo stesso creatore di Sex and the City, non sta raccontando una città, ma sta vendendo un’esperienza emotiva riconoscibile ovunque. Emily non è una persona, è una funzione narrativa. Serve a farci entrare, non a restare.
E infatti Emily non cambia mai davvero. Cambiano i vestiti, i ragazzi, i social network. Lei no. Ed è proprio questo che inquieta. In un mondo che celebra il fallimento come crescita, Emily lavora sempre, sbaglia senza conseguenze e viene premiata anche quando è fuori luogo. Non soffre, non perde e non resta indietro. È irreale non perché è troppo felice, ma perché non può fallire.
Il ruolo “extra” di Lily Collins

Dietro le quinte, però, qualcosa si muove. Lily Collins, spesso liquidata come “Emily”, è anche produttrice della serie. È stata lei a spingere, stagione dopo stagione, per rendere il personaggio leggermente più consapevolee, aggiungerei, meno cartoon. Una correzione minima, certo, ma significativa. Emily in Paris sa di essere osservata, criticata, sezionata. E gioca con questa consapevolezza.
Gli outfit come riconoscimento

La moda, per esempio, non è solo un esibizione visiva, ma è linguaggio. Gli outfit di Emily sono volutamente eccessivi, a volte quasi sbagliati. Servono a farla riconoscere da lontano, a trasformarla in un logo. Emily è un brand ambulante, e come ogni brand vive di discussione, che sia amore o odio, l’ importante che se ne parli.
Sylvie, la vera parigina
Il personaggio più interessante, non a caso, è quello che non cerca consenso: Sylvie. Elegante, scomoda, immobile nella sua identità. Non chiede scusa, non si adatta e, soprattutto, non si spiega. È lei la vera parigina della serie, ed è anche l’unica a sembrare reale. Sylvie non deve piacere al pubblico, ed è per questo che diventa iconica. In un mondo di donne spesso fatte di apparenza, Sylvie è una presenza. Emily, al massimo, una vetrina.
L’amore che non è mai abbastanza amore

E poi c’è l’amore, che sembra centrale ma non lo è mai davvero. I triangoli romantici non portano a niente, le relazioni sono instabili e spesso frustranti. Non c’è una grande storia d’amore da tifare, e forse è voluto. Emily in Paris non è una commedia romantica, ma è una serie sull’ansia da performance emotiva, sul dover essere sempre desiderabili, brillanti e “giusti” al momento giusto.
Alla fine, Emily in Paris funziona perché non chiede profondità. Chiede presenza. È una serie da guardare mentre si fa altro, da commentare, da criticare, da usare come sfondo emotivo. È comfort e irritazione insieme. Ed è proprio questa ambiguità a renderla irresistibile.
Emily non rappresenta Parigi. Rappresenta lo sguardo turistico permanente con cui guardiamo il mondo: sempre pronti a consumare, mai a restare. E forse è per questo che, stagione dopo stagione, continuiamo a seguirla. Non perché ci assomiglia. Ma perché è esattamente ciò che il sistema vorrebbe che fossimo: sorridenti, produttivi, impeccabili. Anche quando siamo fuori posto.